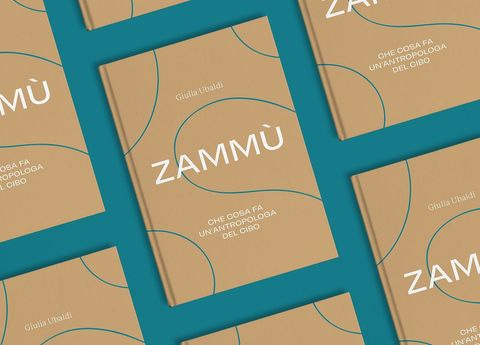Con Giulia Ubaldi ho un’affinità elettiva perché è della Romagna, e ormai avete capito che sono prona ai favoritismi regionali. Poco male. Perché questa storia non parla di una terra, ma di tante. Quelle che si raggruppano attorno al Mediterraneo e pongono a terra la calce e il mattone di un continuum enogastronomico che parla di un solo popolo, diviso dal mare.
Giulia Ubaldi è un’antropologa del cibo. E naturalmente vi starete chiedendo che caspita voglia dire, tutto questo.
Quando stringo la mano a Giulia Ubaldi, mi trovo negli spazi del LAC, il Laboratorio di Antropologia del Cibo che ha fondato a Milano nel 2021, quartiere Giambellino, a pochi passi da una delle istituzioni del quartiere, Libreria Gogol&Company. Il Giambellino è un posto sghembo, affascinante, toccato con mano ancora tangenziale dalle dinamiche della gentrificazone, che qui si è rivolta a una fascia di popolazione di anagrafica un po’ più alta del normale, e ha richiamato famiglie e professionisti oltre i trenta. Quando passeggi in Giambellino, devi stare bene attento ai fianchi: è probabile che un runner ti sfreccerà di fianco, o che dovrai rilanciare la palla a un gruppo di bambini. Ci sono persino degli alberi, sparsi qua e là. Cose che una creatura di Viale Monza come me non vede, letteralmente, tutti i giorni.
Non avrei potuto chiedere setting migliore per incontrare chi, come Giulia, nel diverso ci sguazza. Laurea all’Università di Siena, Giulia mi spiega il suo percorso - e la sua figura - professionale cominciando da una decisione radicale, folle, giustissima: trasferirsi in Cilento per svolgere ricerca per la sua tesi di laurea e poi rimanerci, aprendo un’azienda agricola a produzione zafferano con il compagno dell’epoca ed esplorando di prima mano il legame a doppio filo che unisce gli esseri umani alla terra che abitano.
L’esperienza del Cilento mi ha cambiato radicalmente. Mi ha mostrato la direzione che avrei voluto la mia vita, e la mia attività professionale come antropologa, prendesse. Uno può leggere il tutto nell’ottica della “mattata”, ma in realtà il lavoro dell’antropologo di ricerca è sempre vissuto a contatto diretto con l’oggetto di studio. Lì, volendo, si apre un altro tema, nel senso che un antropologo deve osservare, ma non partecipare, per mantenere la distanza oggettiva sulla sua ricerca. E in Cilento c’erano dei momenti in cui, con lo specchio dell’Accademia, mi rendevo conto di essermi davvero innamorata di quel posto, di esserci dentro. Per esempio: il mio relatore mi faceva notare che usavo come fonti i miei amici, persone che avevano conoscenza diretta della terra e la lavoravano, e dei costumi che questa faceva “sbocciare” nella loro comunità. E li citavo proprio per nome, come se stessi parlando al bar del paese.
Eccoci forse, allora, a una prima pietra fondamentale per capire il lavoro di un’antropologa del cibo: l’indagine dei legami tra cibo e comportamento umano. Che, inevitabilmente, passa anche dal territorio. C’è un confine sottile con l’approccio, e lo sguardo, del giornalista. E infatti, la carriera di Giulia è transitata anche da quelle rive:
A un certo punto, la mia direzione è cambiata ancora. Dopo la rottura con il mio ex-compagno, con cui avevo aperto l’azienda agricola, mi sono ritrovata con le mani vuote, perché era tutto legalmente suo. Allora mi sono detta: voglio iniziare a scrivere, per raccontare tutto quello che avevo imparato, visto, vissuto, e quello che avrei incontrato nel futuro. Il mio materiale era poco noto, avevo esplorato molto il Sud Italia muovendomi tra Campania, Calabria, Basilicata, per esempio, e c’era parecchio interesse verso le storie che portavo.
Inizia così un nuovo periodo, fatto di soddisfazioni ma anche di piccole mosche al naso. Perché l’occhio di una giornalista o di un’antropologa del cibo si fissano su dettagli differenti. E, soprattutto nell’era della comunicazione - e dell’editoria - online, le storie di Giulia rischiavano sempre di venir castrate. Il racconto del territorio e della sua gente, sacrificato sull’altare del click e della ricetta acchiappa-like. Perché tutti vogliamo saper riprodurre quel piatto esotico, ma pochi si soffermano su quello che la preparazione sta effettivamente “portando in tavola”. Oggi, Giulia collabora ancora con Il Giornale del Cibo. La sua attività principale, però, è la sua creatura: il LAC.
Il LAC è il risultato di anni di riflessioni, che mi hanno portato a capire di essere pronta per avere qualcosa di mio. Nel frattempo avevo viaggiato molto, conosciuto molte persone, in Italia ma in tutto il bacino del Mediterraneo. E, se del cibo mi ha sempre affascinato qualcosa, è il potere che esercita sulle persone. Perché puoi essere di fronte a uno sconosciuto, ma, se avete qualcosa da mangiare, vi sentirete già un po’ più intimi. Il cibo, insomma, fa saltare qualche grado di “non conoscenza”. E poi, è un classico: basta menzionare a qualcuno un piatto, un prodotto, una tradizione culinaria della sua zona di origine, e sarete già amici. Il cibo ha davvero un potere notevole.
Specie quello preparato insieme, in casa, sfuggendo dalle logiche patinate del “food” e del fine dining a ogni costo. Sono componenti importanti del panorama, certo. Ma non sono quelle su cui un’antropologa del cibo ha più interesse a concentrarsi.
Ti faccio un esempio stupido per renderti meglio il mio legame con il cibo: quando ero fuorisede a Siena, mentre studiavo all’università, la mia casa, durante i pasti, diventava un porto di mare. Invitavo tutti a cena, cucinavo io per tutti. Cose semplici, ma che facessero stare bene. La pasta zafferano, zucchine e pancetta, per esempio, grande cavallo di battaglia. O alla norma, magari. Quello che ti faceva stare bene e ti dava l’occasione di condividere il tuo tempo con gli altri. Che allora diventava il “nostro” tempo.
È a queste stesse logiche che si ispira il LAC, dove si tengono principalmente corsi condotti sia da chef professionisti che laici del mestiere, provenienti da ogni parte del mondo. Il calendario di maggio recita: pasticceria francese, viaggio nel Balcani, cucina casalinga giapponese, street food di Taiwan, le spezie dell’India, i piatti dell’antica Persia, un immancabile focus-Milano e poi cucina riturale vegetariana dall’Armenia, cucina dominicana dei Caraibi, le ricette delle mamme brasiliane, i tacos messicani, ricette palestinesi, involtini del Vietnam, soul food degli Stati Uniti, cucina bianca ligure, arepas colorate venezuelane, cucina libanese (qui mi fermo altrimenti vi fermate pure voi).
Si è trattato solamente di riprendere tutti i contatti che avevo instaurato nel corso degli anni. Siamo partiti a cannone, nel giro di neanche un anno abbiamo aperto. E la risposta è stata da subito esplosiva, non me la immaginavo minimamente. Quindi il mio 2022 è stato tutto un ottovolante, ma pieno di gioia e soddisfazioni. Oggi mi sono un po’ staccata dalle serate, nel senso che, quando non posso esserci io lavorando tutto il giorno, c’è uno chef professionista messicano che viene a condurre.
Che procedono a ritmo di chiacchiere, degustazioni, e ricette da portarsi a casa. Chiamarla “scuola di cucina” suonerebbe un po’ riduttivo. Anche perché la didattica non è proprio, mi pare, quello che interessa a Giulia. Il contatto, piuttosto, la relazione. Lo scambio di storie ed esperienze attraverso quello che mangiamo.
Viaggiando e studiando i paesi del Mediterraneo mi sono accorta che ci sono dei piatti ricorrenti e davvero “uguali” in tante zone. Un esempio è il pastis, che conosciamo come marsigliese ma che la bevanda “tipica” sulle Alpi Orobie, a Bergamo. Qui c’entrano le migrazioni di ritorno, con italiani emigrati in altri paesi che riportano in patria le tradizioni acquisite all’estero. I liquori all’anice in generale sono un ottimo esempio: con nomi diversi, li si beve in tutto il Mediterraneo, e vogliono dire sempre la stessa cosa. Sei a casa.
Ed è proprio dal liquore all’anice che prende nome «l’ultima delle follie» di Giulia, come la definisce lei: Zammù, un’impresa editoriale indipendente (non lo chiamerei mai libro) di circa 900 pagine in cui Giulia ha raccolto (quasi) tutti i pezzi e reportage che ha pubblicato nel corso degli anni, componendo un atlante delle tradizioni enogastronomiche del continuo mediterraneo. Ci sono foto, testi, gusti, emozioni, rotte, mappe. Forse una guida, se lo userete per indirizzarvi nelle vostre scorribande. Soprattutto, però, un documento del presente e passato del cibo che tutti condividiamo. Il sottotitolo non poteva che essere: “Che cosa fa un’antropologa del cibo”.
Ora ho in lavorazione un’altra impresa: sto mettendo insieme un libro sul LAC e la sua storia, con tutte le ricette che sono passate per le nostre padelle.
Ma Milano, città cosmopolita per eccellenza nell’Italia contemporanea, come ha reagito alla presenza del LAC?
Molto bene. Abbiamo persone che vengono più volte da noi, ci conoscono, e va a finire che si diventa amici. Il nostro publico è molto variegato, non c’è “questo” o “quel” target. La città poi viaggia molto sulle mode, come per tutto il resto. Quindi se l’anno scorso era esploso il cibo thai, e i corsi su quel tema erano sempre sold out, quest’anno vediamo che stanno andando un po’ di più la cucine del Medio-Oriente. Dipende anche dalle notizie sui giornali e dalle situazioni geopolitiche. Si attivano delle curiosità, insomma.
Ma che effetto fa, la metropoli, dopo il Cilento?
All’inizio, impossibile. I primi tempi li passavo sempre in cascina, le ho esplorate tutte, le ho mappate e ci ho scritto articoli. Anche oggi sono molto affezionata a quella dimensione del verde, sia come luoghi che per quello che producono, e infatti cerco sempre di rifornire la cucina del LAC con ingredienti che provengono da questi produttori nelle vicinanze. Ora, però, mi sono abituata anche al cemento. E il capitolo di Zammù su Milano, per completezza, sfiora l’ossessione.
Mentre finisco il bicchiere di vino (buonissimo) che Giulia mi ha offerto, un’ultima domanda per la strada: ma il tuo piatto preferito, qual è? L’antropologa del cibo, qui, mi stupisce ancora una volta, rispondendo a lampo, senza la minima esitazione: gli spaghetti alle vongole. E questo conferma che la casa è sempre il punto fermo su cui possiamo contare.
Prima di andare: vini che mi hanno stuzzicato, recentemente.
Sole Rosso Sangiovese Riserva di Enio Ottaviani. Vino fermo che sembra Lambrusco. Minerale, asciutto, elegante.
In Caso di Sete, Pinot Nero di Patrick Uccelli (Ansitz Dornach). Sorso rapido per un pinot nero insolito e beverino, che io mi berrei volentieri ghiacciato. Ricorda il sorso della Schiava. Color prugna intenso, bouquet al naso delicato. Per scoprire qualcosa di insolito. Lo trovate facile da Signorvino.
Gewürztraminer Gto Macerato, Grawü. Giallo caldo e perlato per un Gewürz che tira alla Malvasia. Regalatelo a quell’amico che, i vini fruttato no, proprio non li posso reggere, e vedrete che cambierà idea. Sempre da Signorvino.
E basta. Ci sentiamo presto.
Fino a quel momento, stay hungry, stay *golosini*.
Cia’.
*Se vuoi essere anche tu, per qualche ragione, un *golosino*, o hai altri *golosini* da consigliare per super chiacchiere, rispondi alla mail, scrivimi su Instagram, e dimmi tutto.